Di Moro
Uno dei fenomeni che permisero alla guerra fredda di perdurare in un regime di particolare “decentramento” dei conflitti è stato quel processo di decolonizzazione che – a partire dall’indomani del secondo conflitto globale – interessò imperi coloniali estesi per milioni di chilometri quadrati. L’abbondanza dei fronti che vedevano contrapposte le sfere di influenza americana e sovietica ha infatti impegnato per decenni un numero spropositato di risorse, di fatto “raffreddando” ulteriormente un conflitto già contenuto grazie al deterrente nucleare.
Sotto questo punto di vista la seconda metà del novecento è stato uno dei periodi più controversi della storia politica, con porzioni intere del pianeta che si governavano sulla base di ideologie morali – oltre che economiche – che vedevano nel proprio stile di vita l’unico e universalmente giusto. Questo vedeva come sfondo una pianificazione attenta della propria geopolitica, con il tentativo da parte dei due poli mondiali – Mosca e Washington – di guadagnare sempre nuove aree di influenza, talvolta anche a scapito dei propri alleati.
Questa ipocrisia si rilevò anche nel processo di decolonizzazione.
Stati Uniti e Unione Sovietica avevano un’opposta visione del mondo, ma ugualmente legittimavano lo smantellamento degli imperi coloniali. Entrambi facevano “dell’autodeterminazione dei popoli” un punto cardine della propria ideologia, ma non si è mai enfatizzato abbastanza quanto questo concetto facesse i loro interessi. Si trattava infatti di stati territorialmente enormi, costituiti da popolazioni spesso ben integrate, risulta scontato quindi come fossero esenti da grandi decolonizzazioni.
D’altra parte, quando, ad esempio, già a seguito della prima guerra mondiale il presidente statunitense Woodrow Wilson presentò i suoi 14 punti, si affermarono principi a favore dell’auto-governo delle nazionalità e alla libera circolazione del commercio al fine di costruire globalmente un clima favorevole all’America. La dissoluzione degli imperi di Vienna, Istanbul e Berlino vede infatti l’ingresso di Washington sulla scena globale e segna il più importante precedente del successivo processo di decolonizzazione.
Questo processo si ripeterà in maniera simile con l’Unione Sovietica alla fine della seconda guerra mondiale. Mosca vide, nel giro di 30 anni, la vittoria della rivoluzione, l’instaurazione di un potere centralizzato, l’industrializzazione massiva, nonché diversi genocidi, crisi delle gerarchie, il rafforzamento di un regime totalitario e il suo ingresso definitivo sulla scena globale a seguito di una guerra costata milioni di morti. Uno stato giovine, che già però iniziava a gettare le basi per l’instaurazione di una rivoluzione globale, in nome dell’anti-imperialismo.
Se a est il vento del comunismo si pavoneggia con una creata stabilità, in occidente si fondavano le basi per il potere degli Stati Uniti. Nella conferenza di Bretton Woods si scrissero le leggi del mondo capitalista. Tra le varie, emersero i principi di interdipendenza economica tra le nazioni e di adozione del dollaro quale valuta di riferimento globale. A parole, creare dipendenze tra le economie avrebbe fatto insorgere nuove guerre, nei fatti, consolidando la sfera di influenza americana, ovviamente ai danni di un’Europa ormai spaccata in due.
Un’istituzione che ha marciato ulteriormente in questo senso è stata l’ONU. Le Nazioni Unite si sono impegnarono a emettere risoluzioni su risoluzioni per l’indipendenza dei territori imperiali. Il Comitato di Decolonizzazione dell’ONU, forte anche dei sempre nuovi membri, optava per un’ulteriore accelerazione del fenomeno, mentre le potenze imperiali erano tenute a impegnarsi in prima persona per il progresso nei possedimenti, dovendo poi fornire alle Nazioni Unite rapporti dettagliati sulla loro condotta.
Indubbio quindi come le potenze coloniali fossero impotenti verso le nuove tendenze globali. La Francia e il Regno Unito, devastate dalla guerra e logorate dal debito, cercarono comunque di fare i loro interessi. Parigi aggrappandosi con le unghie al suo impero, il Regno Unito tentando di costruire nel nuovo mondo un clima a lui favorevole. Entrambi provarono a mantenere un forte controllo economico su determinate zone, riuscendo anche a mantenerlo in alcuni casi. Scontato, come però, il bilancio della partita fu per loro sfavorevole.
Sotto questo punto di vista, i due principali imperi coloniali avevano già forti problemi strutturali, legati ad un’amministrazione dispotica dei territori controllati. In molti casi, le colonie vennero abbandonate dopo neanche un secolo dall’instaurazione del potere, e quei cento anni videro molteplici tensioni e rivolte. Le colonie sostennero fortemente lo sforzo bellico delle madrepatrie durante le guerre ed è grazie allo sfruttamento massivo dei territori che gli imperi passarono le molteplici crisi degli anni ’30.
Alle colonie era però chiesto di portare pazienza in cambio di belle parole e promesse vaghe. Durante la prima e la seconda guerra mondiale le colonie divennero terra di conquista per propagande ed eserciti. La fazione anglo-francese promise, in entrambi i casi, più libertà e più investimenti, stando ben al di sotto delle sue parole in entrambi i dopoguerra. Questo favorì numerosi movimenti indipendentisti, con un malcontento diffuso che avrebbe fornito il pretesto necessario alle pratiche di decolonizzazione.
Nel caso del Medio Oriente, le potenze europee patrocinarono in prima persona una situazione politica instabile. Durante la prima guerra mondiale venne promessa agli arabi una nazione unitaria. Allo smembramento dell’impero ottomano, però, i territori arabi vennero divisi in “mandati”, i quali avrebbero dovuto costituire una transizione verso l’indipendenza. Di fatto, Regno Unito e Francia tenteranno di aggiudicarsi quei territori come una loro area di influenza perenne, dalla quale poter attingere anche dopo l’indipendenza.
Due casi eclatanti furono quelli dell’Iraq e del Libano. Rispettivamente, il Libano si fondò sulla base della comunità cristiana maronita, e il suo territorio ingrandito fino a creare una tripartizione tra cristiani, sunniti e sciiti, radicalizzata in virtù di una rappresentatività su base etnico-confessionale. I maroniti necessitavano della presenza dei francesi per continuare a governare. Questione simile si presentò in Iraq, tra sunniti, sciiti e curdi, che favoriva il predominio economico inglese fondato su una classe dominante sunnita.
In aree dove la diversificazione su base etnico-confessionale non era possibile, il Regno Unito tentò di estendere un controllo economico fondato su una situazione politica instabile. È il caso dell’Egitto, dove, ad esempio, il controllo di Londra su componenti strategiche della nazione finì solo a guerra fredda inoltrata. In particolare, la crisi di Suez del 1956, una disfatta per il Regno Unito, mise in luce come gli obiettivi statunitensi divergessero da quegli europei, e di fatto diede un’ulteriore accelerazione al processo di decolonizzazione.
Questa politica di “eterogenizzazione” funzionò anche a livello macro-regionale. Una strategia su cui contavano sia Europa che America era, similmente all’esperienza della Restaurazione, la creazione di nazioni sostanzialmente in equilibrio, in modo da prevenire la formazione di attori egemoni. La strategia anglo-americana era volta ad equilibrare il potere di Egitto, Arabia Saudita, Iran e Turchia, così da continuare a favorire l’egemonia del “primo mondo” in Medio Oriente. Tutt’oggi l’America fa affidamento su questa strategia.
Nel sud e nel sud-est asiatico si adottò un differente modus operandi. In particolare, la decolonizzazione si ebbe negli anni ’45-’50. Complice l’occupazione giapponese, gli imperi erano oramai più o meno consci del fatto che la restaurazione dello status-quo sarebbe stata impossibile. In particolare, questa parte del mondo conosceva civiltà millenarie dalla forte tradizione nazionale. Esse ricercavano ora una loro indipendenza, spesso prontamente concessa al fine di evitare infiltrazioni comuniste.
È il caso delle Filippine. Nel 1946 gli Stati Uniti le concessero piena sovranità politica, a scapito di quella economica. Nel 1947, lo sconfinato impero anglo-indiano fu diviso tra India e Pakistan, con conseguente indipendenza di Myanmar e Sri Lanka. Questo divenne un caso molto meno pacifico, in quanto la bipartizione venne fatta in maniera frettolosa e su base religiosa, creando gravi lacerazioni e milioni di sfollati. Si voleva evitare ad ogni costo che le già dure violenze portassero ad una crisi che avrebbe avvicinato il subcontinente all’URSS.
Nel 1949 l’Indonesia vinse una guerra d’indipendenza durissima contro l’Olanda. Il vento del comunismo soffiava molto forte sull’arcipelago, perciò a lungo andare si caratterizzò come una nazione autoritaria e del marcato accento capitalista. L’Indocina divenne invece un caso ancor più grave dove in alcun modo si riuscì a instaurare il sistema capitalista, nel 1975, anno che segna la sconfitta delle truppe americane in Vietnam, si rinsaldò il comunismo nella regione e nel giro di pochi anni anche in Laos e Cambogia si consoliderà un governo simile.
Il destino dell’Indocina è stato segnato dalla condotta dell’Impero Francese, il quale tentò in ogni modo di mantenere i suoi territori d’oltremare. Nel 1946, quindi, quando scoppiò la guerra d’Indocina, da Parigi arrivò una risposta intransigente, basata però su un esercito che non la poteva sostenere. L’esercito d’oltralpe fu ripetutamente umiliato dai comunisti Vietminh, finché nel 1954 si ritirò. La situazione che ne conseguì, complice anche il supporto americano a Francia e Vietnam del Sud, fece scoppiare la Guerra del Vietnam.
Il disastro indocinese ebbe un’importanza cruciale nel motivare altri combattenti anti-imperialisti. In Algeria, ad esempio, scoppiò nel 1954 la guerra d’indipendenza. Il territorio era ormai considerato come parte integrante del territorio nazionale e divenì quindi un grave dramma sia per i 500.00 francesi sia per i 9 milioni di arabi quando un conflitto estremamente violento colpì la regione, portando gli europei a scappare nel 1962, lasciando indietro militari e civili sia connazionali che meticci – altro grave disonore per Parigi.
Nel corso della guerra d’Algeria si evinse chiaramente come fosse impossibile mantenere l’impero. Nonostante gli importanti progetti di riforma, i quali avrebbero dovuto vedere la nascita di una gigantesca federazione francese, nel 1960 Parigi concesse l’indipendenza alla maggior parte delle colonie africane. Di punto in bianco, milioni di arabi, neri ed europei si scoprirono cittadini di nazioni nate dal nulla. Ne scaturirono tensioni etniche dovute anche all’egemonia della Francia e dei francesi sulle economie dei nuovi stati.
Le condizioni dei nuovi stati africani e le conseguenze del processo mal gestito di decolonizzazione sono il punto centrale di ogni discussione sulla decolonizzazione. Si tratta dunque, nel complesso, di trattazioni che necessitano di un’attenzione particolare e di un’analisi ed esposizione più dettagliata.
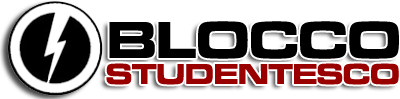





Commenti recenti