di Michele
In questo articolo faremo un’operazione particolare. Faremo una critica che a prima vista potrà sembrare fuoco amico, perché metteremo in questione il sovranismo o almeno un sovranismo. Ma questo articolo vuole essere un abbozzo, un inizio, un percorso da costruire e non una ricetta già confezionata.
Partiamo da un dato che forse non ci piacerà: la politica si sta normalizzando. Gli elementi di novità che hanno caratterizzato le bagarre elettorali post-berlusconiane stanno venendo riassorbite. La santa alleanza fa Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ha definito questi ultimi come sinistra, ha sancito la fine del Movimento come voto di protesta e ha confinato il suo populismo a semplice strategia comunicativa, ovvero come ulteriore passo nella de-ideologizzazione della politica.
Dall’altra parte Salvini e Meloni stanno riproponendo una destra sempre più conservatrice e sempre meno sovranista. Vediamo ricomporsi un centro-destra abbastanza classico, con un partito poco ideologizzato ma con un leader carismatico (prima erano Forza Italia e Berlusconi, oggi Lega e Salvini), uno con una forte caratterizzazione di destra (Fratelli d’Italia occupa lo spazio che era di Alleanza Nazionale), ed un partito che serve come garanzia verso il sistema, ovvero come centro (Forza Italia svolge la funzione della passata Udc).
La crescita di partiti come FdI e Lega hanno fatto insorgere alcune illusione ottiche. Ci siamo abituati a pensare che la destra stia vincendo e che la politica si stia polarizzando. Al contrario la destra sta lentamente perdendo terreno semplicemente perché ciò che ad essa viene imputato come estremismo solo vent’anni fa era la normalità. Questo smottamento è visibile sui molti temi caldi di oggi, come l’immigrazione o l’interesse verso certe minoranze ad esempio quella LGBT+ (anche il fatto di aver aggiunto un “+” a tale sigla dovrebbe valere come esempio). Ciò dovrebbe farci riflettere anche sul valore del conservatorismo come strategia politica, il quale al massimo può avere un effetto ritardante ma mai risolutivo.
In tutto questo come e dove si inserisce il sovranismo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima pensare a dare una definizione al concetto di sovranismo. Come tutte le nomenclature della politica, il sovranismo non ha una definizione precisa e agisce come un attrattore di significati e come strumento operativo. Nonostante questo, possiamo dire che il sovranismo nasce con il riconoscimento di un avversario, ovvero il globalismo, e con la consapevolezza che sulla frattura fra sovranismo e globalismo si gioca la vera partita politica della nostra epoca.
La fine del berlusconismo ha rappresentato anche la crisi di un modello che vedeva conservatorismo e progressismo come il campo di gioco della politica. Ciò significa che il sovranismo ha rappresentato un interessante tentativo di superare questo binomio. Ma ciò significa anche che il sovranismo ha una forte caratterizzazione europea, nel senso che quello della sovranità è un problema che riguarda i popoli europei in particolare, poiché ad oggi sono questi a soffrire una mancanza di sovranità più di tanti altri. Più di altri non perché abbiano meno sovranità in assoluto, piuttosto perché ne hanno persa più di tutti, avendo perso la propria centralità storica che era dominante fino al secolo scorso.
Mentre i principali attori italiani del sovranismo hanno subito una normalizzazione, il sovranismo ha cominciato ad essere confuso come semplice spazio altro rispetto al globalismo, come ricettore di tutto ciò che è protesta anti-establishment, cambiando il suo bacino di utenza e invecchiando inesorabilmente. In altre parole, il sovranismo è diventato boomer.
I boomer sono coloro che sono nati nel boom economico del secondo dopoguerra. Nell’immaginario collettivo il boomer è chi si dimostra insofferente ad ogni novità, chi aprirà qualsiasi discorso con “ai miei tempi”, e che per contrappasso verrà deriso con un “ok, boomer”. Quindi per sovranismo boomer intendiamo un sovranismo retrivo e che si muove goffamente nel mondo di oggi. Ma non è solo questa componente nostalgica che vogliamo sottolineare. C’è qualcosa di profondamente sbagliato anche nell’oggetto di questo nostalgismo.
Coerentemente con la caratterizzazione negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, c’è una idealizzazione di quell’epoca storica. Lo vediamo sul piano economico con la mitizzazione di Keynes e di certe politiche economiche. Ma lo vediamo ancora di più con la rappresentazione di un certo modello di società. Al netto delle incomprensibili battaglie della sinistra progressista e delle continue decostruzioni a cui assistiamo, la società borghese di quegli anni ha effettivamente qualcosa di rassicurante. Parliamo infatti di anni in cui benessere materiale ed eguaglianza sociale si andavano diffondendo, raggiungendo livelli superiori anche a quelli attuali. Dal nostro punto di vista, però ciò non può bastare. L’idillio di una società di sani e vecchi valori, semplicemente non regge perché quelli erano i valori di una borghesia omologante e consumista, erano i valori di una Europa che aveva già perso il suo posto nel mondo. È proprio l’immagine di una società irenica, senza conflitto, appiattita sulle piccole cose, intrisa di materialismo, e che vive una vita bigotta, che vogliamo rifiutare. Il secondo dopoguerra è già di per sé la vittoria dell’ultimo uomo. È bene ricordare invece che noi aneliamo al superuomo.
Paradossalmente – ma forse nemmeno tanto – questa nostalgia verso un’idea di società tranquillizzante e per certi versi rigida, si coniuga con una esaltazione della libertà, intesa come libera coscienza e contrarietà all’autorità, che è invece un retaggio sessantottino. Questa libertà viene coniugata in senso negativo, come libertà da. Siamo quindi finiti in una teoria della liberazione che legge il mondo unicamente nel conflitto tra oppressi (buoni) e oppressori (cattivi), com’erano quelle di Marx o di Marcuse. Ma è lo stesso retroterra culturale delle battaglie più spinte del progressismo, della cultura del piagnisteo, del politicamente corretto che trova sempre nuove e più bislacche minoranze da liberare dalla maggioranza.
In questo senso, il sovranismo boomer è una sorta di cannibalizzazione della sinistra da parte di sé stessa. La maggioranza si trova a vivere nel mondo della cosiddetta discriminazione positiva, un mondo in cui le minoranze sono maggioritarie perché privilegiate. Così la maggioranza si scopre discriminata proprio in quanto maggioranza, e finisce per adoperare il linguaggio e gli strumenti politici delle minoranze, che sono da sempre quelli della sinistra. L’idealizzazione del popolo sovrano tradito dai poteri forti, una certa sopravvalutazione della democrazia diretta, alcuni toni vittimistici, così come la movenza, in apparenza contraria ma in realtà complementare, del complottismo, vengono da qui.
Fino ad ora ci sono stati pochi tentativi di tradurre l’idea di sovranismo e di sovranità con una diversa idea di libertà, diversa dall’idea di libertà come emancipazione di cui abbiamo detto fin qui. Dovremmo provare a re-immaginare una libertà positiva, una libertà come funzione, una libertà per, una libertà organica. Una libertà che riconosca una gerarchia e una comunità. Idealmente è la stessa operazione di Jünger ne L’operaio, quando toglie la figura del lavoratore alla narrazione marxista per rivestirlo di una libertà di rango superiore.
Ma torniamo su un tema tipico del sovranismo boomer: il complottismo. Tralasciando il fatto che la battaglia contro le fake news sia a tutti gli effetti uno strumento ideologizzato, qui ci interessa vedere il complottismo sotto due aspetti, quello della semplificazione e quello della perdita di centralità storica. Partiamo da una premessa, il complottismo non ha contenuto, è semplicemente un modo tra gli altri di vedere le cose. In altre parole, è una narrazione. Questa narrazione, però, ci dice qualcosa riguardo chi la usa.
Innanzitutto il complottismo è a-storico, perché vede la storia come un processo chiuso, ovvero deciso a priori da entità occulte. Questo è sintomatico rispetto alla perdita di centralità storica dei popoli europei, ma diviene parte del problema in quanto negazione della storia tout court. La storia è il campo delle possibilità, dell’imprevisto, del pericolo e del conflitto, non vi è libertà umana che sia fuori di essa.
In seconda battuta, il complottismo è un modo di semplificare il reale, rendendolo non solo meno complesso, ma in qualche modo anche meno politico. Il complottismo ha le stesse caratteristiche di un messaggio pubblicitario. La sua iper-semplificazione e spesso la sua brevità sono funzionali per facilitarne la fruizione e la diffusione. Allo stesso modo cerca un aggancio emotivo e una esasperazione dei toni, pur partendo da situazioni di normalità e quindi riconoscibili, così da catturare l’attenzione del fruitore.
Tuttavia questi aspetti caratteristici del complottismo sono del tutto comuni alla narrazione tipica del globalismo. Ciò che di solito distingue il complottismo dal politicamente corretto è una patina di amatorialità, una certa grossolanità, e un’estetica poco curata.
Arrivati a questo punto potrebbe venire da chiedersi se il sovranismo sia ancora utile come categoria politica o vada piuttosto abbandonato. Qualsiasi definizione politica deve essere vista nella sua capacità di mobilitare. In questo senso il dibattito intorno al sovranismo, addirittura le sue contraddizioni, fanno sperare che in esso ci sia ancora vitalità. Il sovranismo è qualcosa di più di un nazionalismo e qualcosa di più di un conservatorismo, ma è anche qualcosa di più di una ricetta economica e del vittimismo anti-UE. Il sovranismo deve abbandonare lo stile e i contenuti boomer. Riscoprire la sovranità significa credere in una comunità di destino. Per aprire nuove e future direttrici del sovranismo, sarà nostro compito riflettere fino in fondo sulla corrispondenza fra sovranità e imperium.
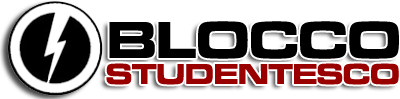





Commenti recenti