Di Marco
Il linguaggio è uno degli strumenti con cui l’Uomo fin dalle origini struttura il proprio pensiero e lo comunica ad un altro individuo. La possibilità di poter articolare quello che si vuole esprimere mediante l’utilizzo di molteplici sfumature è una caratteristica propriamente umana.
L’utilizzo della parola e la possibilità di associarla a delle immagini è una peculiarità che ci divide dal mondo animale e ci permette di poter elaborare e trasmettere pensieri, idee e concetti molto complessi. Appare evidente, dunque, l’importanza del linguaggio nella vita dell’Uomo e nello sviluppo di società complesse e articolate.
Come tutti gli altri strumenti, la Parola dà la possibilità a coloro che sanno padroneggiarla e utilizzarla con maggiore abilità di porsi su un gradino superiore rispetto agli altri. Da sempre nei secoli e nelle diverse civiltà, coloro che hanno saputo utilizzare con maggiore scaltrezza “l’arma” della Parola sono stati anche coloro che hanno saputo influenzare le masse e dominarle.
Il formidabile potere di questo strumento, di saper orientare e suggestionare le folle, è stato analizzato e studiato da uno dei più importanti sociologi francesi, vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo, nella sua opera, divenuta poi celebre in tutto il mondo, intitolata “La psicologia delle folle”. Lo studioso in questione, Gustave Le Bon, nel suo saggio approfondisce che la capacità di saper controllare le masse non sta solo nel potere di coercizione o di punizione, ma bensì nell’abilità di saper controllare la comunicazione che è fatta sia di parole che di immagini.
A proposito di questo Le Bon nella sua opera scrive: “Certe parole sembrano possedere un potere magico formidabile. Migliaia di uomini si son fatti uccidere per parole di cui non hanno mai compreso il significato, e spesso anche per parole che non hanno nessun significato”. L’analisi compiuta da Le Bon sul potere delle parole emerge proprio quando le masse iniziano ad assumere un ruolo sempre maggiore nella vita politica degli Stati.
La sua opera, bisogna ricordare, viene pubblicata nel 1895 a pochi anni dall’inizio del secolo che ha visto come protagoniste le folle e di questo Le Bon ne era consapevole quando dice: “Mentre le nostre antiche credenze vacillano e scompaiono, e le vecchie colonne a mano a mano sprofondano, l’azione delle folle è l’unica forza non minacciata e il cui prestigio ogni giorno si accresce. L’epoca in cui entriamo, sarà veramente l’Era delle folle”.
L’analisi lucida del sociologo francese, dunque, sottolinea l’importanza, per chi vuole comandare, di saper impressionare le masse e lo strumento adatto per farlo non è il ricorso alla violenza, bensì l’uso studiato e attento di una comunicazione che sappia far presa sulle emozioni dei singoli individui. Solo chi avrà saputo “parlare alla folla” nel modo corretto godrà del suo pieno sostegno e della sua piena attenzione.
L’analisi di Le Bon, contenuta nel suo libro “La Psicologia delle Folle” ha avuto un’eco impressionante in tutto il XX tanto da attrarre l’attenzione di uno dei maggiori protagonisti di questa “Età delle Folle”, ossia Benito Mussolini, il quale nel ‘26 scrive: “Ho letto tutta l’opera di Le Bon e non so quante volte abbia riletto la sua Psicologia delle folle. È un’opera capitale alla quale spesso ritorno.”
Dall’analisi compiuta dal sociologo francese sull’importanza che bisogna prestare all’utilizzo delle parole e delle immagini, potente strumento di suggestione delle masse, per ottenere e mantenere nel tempo il controllo delle folle e quindi del potere in sé, emerge un’altra figura che nel corso del XX secolo si è interessata e ha analizzato l’importanza di mantenere e controllare le folle: Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista italiano e figura di rilievo in diversi campi del sapere che ha saputo elaborare una visione della realtà che è andata oltre alla sua breve vita. La figura di Gramsci non può che non essere associata al concetto da lui stesso elaborato di “egemonia culturale”, espressione che indica le varie forme di «dominio» culturale da parte di un gruppo o di una classe che sia in grado di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche quotidiane e credenze condivise, i propri punti di vista fino alla loro interiorizzazione, creando i presupposti per un complesso sistema di controllo.
L’egemonia culturale, quindi, sta a indicare che, attraverso la capacità di orientare la mentalità, l’elaborazione simbolica, gli stili di vita e i linguaggi della «massa popolare-nazionale», «i gruppi dirigenti» stabiliscono «rapporti più intimi» con essa. In altre parole, consolidano e stabilizzano la loro supremazia. L’egemonia culturale è dunque il sistema arterioso dell’egemonia politica, ma ne è solo un aspetto, anche se imprescindibile. Questa lezione gramsciana ha fatto scuola a un’intera generazione di professionisti, come professori, giudici e giornalisti che nel corso della seconda metà del XX, riprendendo il concetto di “egemonia culturale”, hanno cercato di imporre la propria visione del mondo mediante gli strumenti a loro disposizione: lezioni “politicizzate” e insegnamento scolastico fazioso; sentenze giuridiche non sempre limpide; articoli e servizi televisivi volti a “demonizzare” l’avversario politico e a far passare per buona un’unica verità di pensiero.
I risultati di questa azione silente compiuta nel corso del degli anni si vedono adesso, dove nelle scuole l’insegnamento di materie “sensibili”, come la Storia, sono in mano a professori che sminuiscono o saltano addirittura interi periodi storici, solo perché non conformi all’etichetta del pensiero egemone; nei giornali si assiste a una martellante propaganda dispregiativa contro l’avversario politico di turno, i cui metodi ricorda molto la pratica, descritta da Orwell nel suo romanzo “1984”, dei “Due minuti d’odio”; sui social, “nuovo” spazio del dibattito politico, si censurano post o intere pagine di gruppi o esponenti di partiti politici poiché non allineati al dogma del pensiero egemone.
L’insegnamento che si può trarre dall’analisi compiuta da Le Bon nel suo “Psicologia delle folle” e dal concetto elaborato da Antonio Gramsci è il seguente: per stare a capo di una Nazione o di un gruppo molto numeroso di persone, non basta saper dominare con il potere della coercizione e della paura, ma c’è bisogno che “coloro che stanno sotto” non mettano in discussione chi sta al potere e che addirittura giustifichi la presenza di quello stesso potere, ma questo può accadere solo quando la Cultura del gruppo egemone diventa la stessa della massa.
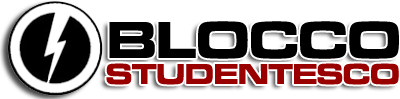





Commenti recenti